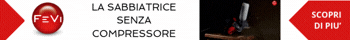Opere abusive su edifici storici: quando il ripristino è obbligatorio
Il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di ripristino per opere abusive su immobile vincolato, respingendo le eccezioni su usucapione, impossibilità tecnica e ritardo del procedimento amministrativo.


Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha riacceso i riflettori su un tema particolarmente delicato: la compatibilità tra interventi edilizi e tutela dei beni culturali. Al centro della vicenda, un immobile situato nel centro storico di Padova, soggetto a vincolo architettonico, su cui erano state realizzate alcune opere non autorizzate.
Il Ministero della Cultura ha emesso un provvedimento di ripristino dello stato originario dell’edificio, ritenendo le modifiche incompatibili con la tutela prevista dalla legge.
Il proprietario ha impugnato l’atto, sostenendo da un lato la pendenza di un giudizio civile per usucapione, e dall’altro l’impossibilità tecnica della demolizione senza compromettere la staticità dell’edificio. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno respinto l’appello, ribadendo la legittimità dell’intervento repressivo.
Quali sono i confini dell’attività edilizia su immobili vincolati? Quando può dirsi davvero impossibile un ripristino? E cosa succede se parallelamente è in corso una causa civile sulla proprietà?
Sommario
Il vincolo architettonico e l’obbligo di reintegrazione
Nel cuore della vicenda si trova l’applicazione dell’articolo 160 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), che stabilisce un principio chiaro: se un bene culturale è alterato da interventi non autorizzati, l’amministrazione può ordinare al responsabile il ripristino dello stato originario.
Si tratta di un potere vincolato, non discrezionale, che scatta automaticamente in presenza di una violazione accertata.
In questo caso, la Soprintendenza aveva rilevato una serie di opere abusive — tra cui una terrazza a pozzetto, impianti tecnologici e aperture irregolari — che modificavano in modo sostanziale un edificio tutelato. L’ordine ministeriale ha pertanto imposto la reintegrazione entro 180 giorni, lasciando al proprietario la possibilità di presentare un progetto esecutivo conforme da sottoporre all’approvazione della Soprintendenza stessa.
Questa impostazione evidenzia come, in materia di tutela dei beni culturali, la repressione dell’abuso edilizio non ammette compromessi: il principio del “tempus regit actum” fa sì che ciò che conta sia la situazione giuridica al momento dell’accertamento, indipendentemente da controversie civili o richieste di sanatoria.
Leggi anche: Nessuna sanatoria per chi cambia destinazione d’uso: parla il Consiglio di Stato
L’usucapione non blocca l’ordine di ripristino
Uno dei principali argomenti portati dalla difesa del proprietario era legato a una causa civile in corso per l’accertamento dell’usucapione delle porzioni di immobile interessate dagli interventi contestati. Secondo questa tesi, se il giudice civile avesse riconosciuto la proprietà esclusiva al ricorrente, il condominio non avrebbe avuto titolo a intervenire né a contestare le opere.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha respinto tale impostazione, chiarendo che l’ordine di ripristino è diretto non al soggetto proprietario, ma all’autore dell’abuso edilizio.
Ciò significa che, anche qualora fosse accertata la proprietà esclusiva delle porzioni alterate, l’obbligo di riportare lo stato dei luoghi alla situazione originaria rimarrebbe valido. Inoltre, il condominio mantiene comunque un interesse legittimo alla corretta esecuzione del ripristino, soprattutto quando le opere impattano su elementi comuni dell’edificio.
Per i giudici, quindi, non sussiste alcuna pregiudizialità tra il giudizio amministrativo e quello civile: la controversia sull’usucapione non influisce sulla legittimità del provvedimento repressivo.
Leggi anche: Chi possiede un immobile abusivo deve dimostrare la legittimità delle opere e la data di realizzazione
Impossibilità tecnica? una questione da valutare in fase esecutiva
Un altro punto centrale sollevato dal ricorrente riguardava l’impossibilità tecnica di eseguire il ripristino richiesto senza compromettere la stabilità strutturale dell’edificio. Questa argomentazione puntava a invocare l’applicazione del comma 4 dell’articolo 160 del Codice dei Beni Culturali, che prevede – in alternativa alla reintegrazione materiale – una sanzione pecuniaria qualora la demolizione non sia tecnicamente realizzabile.
Tuttavia, anche in questo caso il Consiglio di Stato ha ribadito un principio fondamentale: l’obbligo di reintegra è la regola, la sanzione pecuniaria l’eccezione, applicabile solo quando sia dimostrata l’assoluta impossibilità dell’intervento.
Nel caso in esame, i giudici hanno rilevato che l’impossibilità tecnica addotta dal ricorrente non è stata sufficientemente provata, né è emersa da una valutazione oggettiva svolta dagli enti preposti. Anzi, la Soprintendenza aveva individuato in modo puntuale le opere da rimuovere e le modalità con cui eseguire gli interventi, rimandando l’approvazione definitiva a un progetto tecnico da sottoporre all’Amministrazione.
Eventuali criticità potranno, eventualmente, essere valutate solo nella fase esecutiva, previa segnalazione specifica e documentata da parte del privato.
Legittimità dell’ordine anche se tardivo
Un’ulteriore censura mossa contro il provvedimento ministeriale riguardava il lungo tempo trascorso dall’avvio del procedimento alla sua conclusione: oltre cinque anni. Secondo il ricorrente, questo ritardo avrebbe richiesto una motivazione specifica da parte dell’Amministrazione, in base ai principi generali di trasparenza e buona amministrazione.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ricordato un orientamento consolidato: l’ordine di demolizione, anche se adottato a distanza di tempo, rimane legittimo quando l’opera è abusiva e non vi è alcun titolo edilizio o autorizzazione che la giustifichi.
Leggi anche: Abusi edilizi: il TAR conferma che il tempo non sana l’illegittimità
Secondo la giurisprudenza, un provvedimento repressivo di questo tipo ha natura vincolata e non richiede motivazioni ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata. Neppure il fatto che l’attuale proprietario non sia l’autore materiale dell’abuso o che l’immobile sia stato trasferito nel tempo può incidere sulla validità dell’ordine. L’unico interesse pubblico rilevante resta quello alla rimozione dell’intervento non autorizzato e al rispetto delle regole urbanistiche e di tutela.
La sentenza del Consiglio di Stato: prevale la tutela del patrimonio
Con la sentenza n. 1744 del 2025, il Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva la legittimità dell’ordine ministeriale di ripristino, respingendo tutti i motivi di appello sollevati dal proprietario. I giudici amministrativi hanno chiarito che l’ordine di reintegrazione non richiede una motivazione specifica in merito all’interesse pubblico, essendo un atto vincolato, previsto espressamente dal Codice dei Beni Culturali in caso di interventi abusivi su immobili vincolati.
Né il protrarsi del procedimento per oltre cinque anni, né l’invocata usucapione, né la presunta impossibilità tecnica del ripristino sono stati ritenuti ostacoli validi. Al contrario, la sentenza sottolinea che il potere repressivo in materia di tutela del patrimonio culturale è autonomo rispetto a qualunque controversia civile, e che la demolizione delle opere può essere evitata solo se e quando sia dimostrata la concreta impossibilità esecutiva, valutabile in fase successiva.
Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese processuali poste a carico del ricorrente, con una condanna pari a 4.000 euro.
Richiedi informazioni per Abuso edilizio, Edilizia Urbanistica, Notizie
Articoli Correlati


Affitti brevi: ecco quando scatta la presunzione di imprenditorialità
02/02/2026 15:18 - Dal 2026, gli affitti brevi diventano attività imprenditoriale dal terzo immobile. Obbligatori SCIA, partita IVA e rispetto delle normative locali. Sanzioni fino a 10.000 euro per chi non si adegua.

Vita in condominio: si può vietare lo stendino al vicino?
02/02/2026 08:30 - La sentenza chiarisce quando un comportamento in condominio diventa illegittimo, [..]

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): cos’è e perché è centrale nei cantieri edili
02/02/2026 08:11 - Struttura obbligatoria [..]

Casa con infiltrazioni scoperte dopo l’acquisto: “visto e piaciuto” non basta
31/01/2026 09:05 - Infiltrazioni emerse [..]