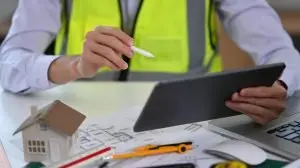Sanatoria edilizia su immobili condonati: stop dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato stabilisce che le opere abusive su immobili condonati non possono essere sanate ordinariamente: il condono non conferisce piena legittimità urbanistica, ma solo tolleranza giuridica.


La recente sentenza n. 482/2025 del Consiglio di Stato affronta un tema tanto tecnico quanto cruciale per chi opera nel settore edilizio: si può ottenere una sanatoria per opere realizzate su immobili già condonati? La risposta fornita dai giudici è chiara e destinata a fare scuola. Il caso esaminato riguarda la richiesta di regolarizzazione di alcune opere costruite in assenza di titoli abilitativi, in un contesto già interessato da una domanda di condono edilizio risalente agli anni ’90.
Ciò che rende la decisione particolarmente rilevante è la netta separazione tracciata dai giudici tra condono edilizio e sanatoria ordinaria, due strumenti spesso confusi ma profondamente diversi per natura, effetti e limiti applicativi. Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato chiarisce che le opere condonate non godono di piena legittimità urbanistica e non possono fungere da base per ulteriori interventi edilizi, se non per quelli meramente manutentivi.
Ti sei mai chiesto se è possibile ampliare o modificare un immobile già condonato? Oppure se un’opera abusiva può essere comunque sanata anche se realizzata in zona vincolata?
Sommario
I fatti: una sanatoria richiesta su opere realizzate in attesa di condono
Il caso analizzato nella sentenza ha origine da una richiesta di sanatoria edilizia presentata nel 2009 per alcune opere realizzate in assenza di titolo abilitativo. L’istanza veniva formulata ai sensi dell’articolo 37 del DPR 380/2001, che disciplina l’accertamento di conformità postumo per opere eseguite senza permesso, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.
Il nodo centrale, però, risiedeva nel fatto che queste opere insistevano su un immobile già oggetto di una precedente domanda di condono edilizio, presentata negli anni ’90 ai sensi della legge 724/1994, e tuttora non ancora definita dall’amministrazione comunale. In particolare, le opere oggetto della sanatoria includevano ampliamenti di fabbricati, pertinenze come garage e legnaie, nonché un pergolato e un’area cementificata.
Secondo il ricorrente, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto sospendere ogni valutazione sulla sanatoria in attesa della definizione del procedimento di condono. Inoltre, venivano sollevate una serie di censure sul mancato rispetto delle garanzie procedimentali (come la comunicazione dei motivi ostativi) e sulla qualificazione delle opere come attività di edilizia libera o comunque pertinenze non soggette a permesso di costruire.
Il TAR respinge: vincoli paesaggistici e limiti del condono
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania aveva già respinto il ricorso in primo grado, ritenendo inammissibili alcune censure e, soprattutto, evidenziando come le opere realizzate fossero incompatibili con la disciplina paesaggistica. Secondo il TAR, il pergolato non poteva qualificarsi come struttura precaria e quindi non rientrava nell’edilizia libera, mentre il garage non poteva essere considerato una mera pertinenza, in quanto produceva nuova volumetria urbanisticamente rilevante.
Inoltre, l’area risultava soggetta a vincolo paesaggistico, per cui – ai sensi dell’art. 167, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 – non sarebbe comunque stato possibile rilasciare una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica. Di conseguenza, anche in presenza di una domanda di sanatoria, mancavano i presupposti per una regolarizzazione.
Il TAR aveva infine chiarito che la pendenza di una domanda di condono non paralizza l’amministrazione, che può comunque esprimersi su richieste autonome di sanatoria presentate successivamente, purché lo faccia in modo motivato. Nel caso in esame, la presenza del vincolo e la natura urbanisticamente rilevante delle opere bastavano a giustificare il rigetto.
Il Consiglio di Stato chiarisce: il condono non legittima ulteriori interventi
Nel riesaminare il caso in appello, il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto del ricorso, ma ha riformulato in modo più incisivo la motivazione, offrendo una lettura rigorosa e chiarificatrice del rapporto tra condono edilizio e legittimità urbanistica. Secondo i giudici, le opere abusive oggetto di condono non acquisiscono la piena conformità agli strumenti urbanistici e paesaggistici, ma ottengono solo un effetto “sanante” limitato: evitano la demolizione e possono circolare giuridicamente (ad esempio, in caso di compravendita), ma non diventano automaticamente conformi alla normativa vigente.
In questa prospettiva, un’opera condonata non può essere equiparata a un immobile regolarmente autorizzato con permesso di costruire o con altro titolo edilizio. Questo principio ha conseguenze pratiche fondamentali: non è ammessa la presentazione di istanze di sanatoria ordinaria (ex art. 36 o 37 del DPR 380/2001) per opere che costituiscano ampliamenti, pertinenze o trasformazioni edilizie fondate su immobili già condonati, perché si tratterebbe di “regolarizzare sull’irregolare”.
Il condono, spiegano i giudici, ha natura eccezionale e straordinaria, ed è legato a specifici limiti temporali e procedurali. Estenderne gli effetti oltre quei limiti significherebbe attribuirgli una “ultrattività indefinita” che non trova fondamento nella legge. È per questo motivo che, nel caso di specie, tutte le opere aggiuntive (dall’area cementificata al pergolato, fino ai locali di servizio) sono state considerate non sanabili, proprio perché poggiavano su un edificio già oggetto di una domanda di condono ancora pendente.
In sintesi, la sentenza sancisce che un abuso su un abuso non può essere legittimato, e che solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o risanamento conservativo possono essere ammessi su un immobile condonato, proprio per rispettare il perimetro ristretto con cui il legislatore ha regolato il condono edilizio.
Richiedi informazioni per Abuso edilizio, Condono Edilizio, Notizie
Articoli Correlati
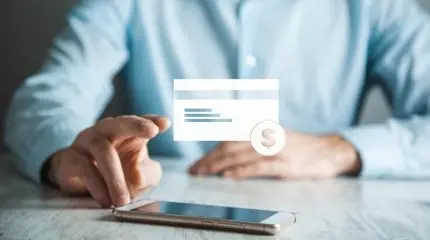

Bonifico ordinario invece del parlante: si perde la detrazione? cosa dice il Fisco
13/02/2026 12:48 - Errore nel bonifico per lavori energetici? La detrazione resta possibile se l’impresa certifica la corretta contabilizzazione dei corrispettivi. Fondamentali documentazione, dichiarazione sostitutiva e verifica sostanziale fiscale.

Assegno di inclusione 2026: calendario ufficiale dei pagamenti e date da segnare
13/02/2026 09:23 - Calendario ufficiale [..]

Mutuo ipotecario e usufrutto: quando spetta la detrazione degli interessi passivi?
13/02/2026 09:00 - Detrazione del 19% [..]

Bonus ristrutturazioni 2026: tapparelle e serrande sono agevolabili?
13/02/2026 08:31 - Nel 2026 la [..]