Cedolare secca al 26% sugli affitti brevi: cosa cambia davvero con la Manovra 2026
L’aumento al 26% della cedolare secca sugli affitti brevi colpisce anche la prima casa, con forti ripercussioni su piccoli proprietari, turismo, mercato immobiliare e indotto economico.
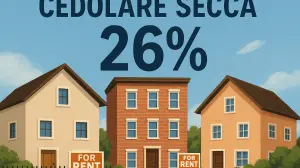
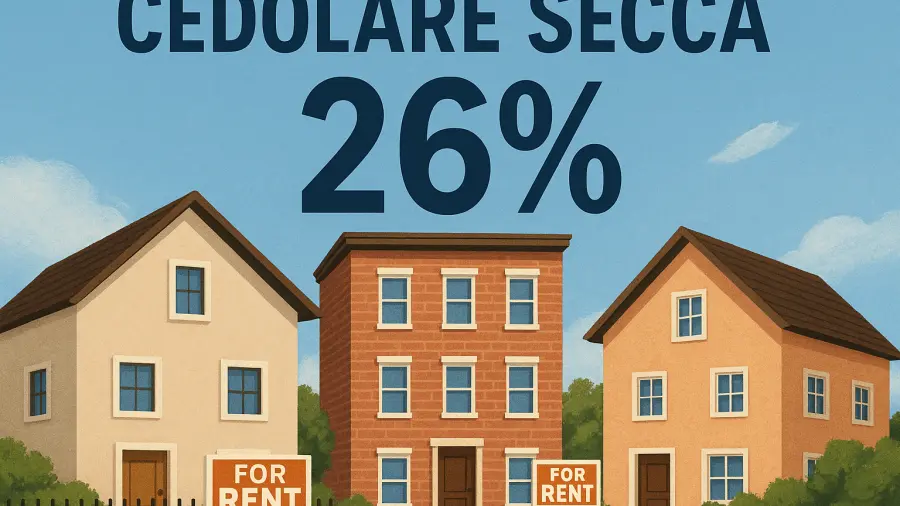
Affitti brevi, cambia tutto: con la nuova manovra 2026 arriva la cedolare secca al 26% anche sulla prima casa data in locazione. Una stretta fiscale inattesa che potrebbe incidere in modo rilevante sulle scelte di migliaia di piccoli proprietari italiani. La misura, contenuta nella bozza della Legge di Bilancio, cancella di fatto l’agevolazione introdotta nel 2023, che permetteva una tassazione agevolata al 21% almeno sul primo immobile.
Secondo le associazioni di categoria, il colpo si farà sentire soprattutto sul ceto medio, ovvero su chi ha ereditato un’abitazione o l’ha messa a reddito per necessità.
Ma qual è il vero impatto di questa riforma? A chi conviene davvero e chi, invece, rischia di perdere di più? E cosa cambierà per il mercato immobiliare e per il turismo?
Leggi anche: Manovra 2026: cosa cambia per tasse, bonus casa, pensioni e famiglie
Sommario
Cedolare secca al 26% anche sulla prima casa: cosa prevede la nuova norma
La bozza della manovra 2026 contiene una modifica cruciale per chi affitta immobili a breve termine: la cedolare secca salirà dal 21% al 26% già dalla prima abitazione locata. Una svolta che azzera l’eccezione introdotta l’anno precedente, secondo cui la tassazione più alta si applicava solo dal secondo immobile in poi.
L’obiettivo dichiarato del governo è quello di ridurre l’utilizzo degli affitti brevi, considerati una delle cause dello svuotamento dei centri storici e dell’aumento dei prezzi degli alloggi per residenti.
Tuttavia, a pagare il prezzo più alto rischiano di essere proprio i piccoli proprietari, quelli che mettono a reddito un’unica abitazione, spesso frutto di eredità o non utilizzata per motivi personali. L’aumento dell’aliquota potrebbe tradursi, secondo le stime dell’Aigab, in una perdita netta annua di circa 1.300 euro per famiglia.
Leggi anche: Affitto senza cedolare secca: come funziona l’adeguamento Istat nel 730
Chi affitta a breve termine? un identikit dei proprietari penalizzati
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il mercato degli affitti brevi in Italia non è dominato da grandi società immobiliari, ma da singoli cittadini. Secondo i dati del Centro studi Aigab, il 96% degli immobili offerti online appartiene a proprietari privati, e nel 30% dei casi si tratta di abitazioni ereditate, messe a reddito per evitare che restino inutilizzate. Altri lo fanno per necessità: quasi il 29% ha scelto di affittare la propria ex casa per far fronte a spese crescenti o situazioni economiche instabili.
La nuova tassazione colpisce quindi un segmento di popolazione che spesso affitta non per speculare, ma per sopravvivere o integrare un reddito insufficiente. Penalizzarlo potrebbe avere effetti a catena sull’intero sistema economico e sociale delle città.
L’aumento della tassazione sugli affitti brevi non è una questione che riguarda solo i proprietari: potrebbe avere ripercussioni significative anche sul turismo e sull’economia urbana. Secondo Aigab, già nel 2025 si è registrato un calo di oltre 40 mila case disponibili sulle piattaforme online. Questo trend, legato all’incertezza normativa e alla pressione fiscale, potrebbe accentuarsi nel 2026, riducendo l’offerta turistica alternativa nelle città italiane.
Meno case disponibili significa prezzi più alti per i viaggiatori, minore competitività rispetto ad altri Paesi europei e una potenziale perdita per l’intero indotto: ristoranti, negozi, servizi locali e perfino gli hotel, che beneficiano di una presenza turistica diversificata. Inoltre, l’abbandono di immobili in zone periferiche o meno centrali potrebbe vanificare gli sforzi di riqualificazione urbana avviati negli ultimi anni.
Leggi anche: La cedolare secca continua a crescere, ecco perché convince sempre più italiani
Le proposte delle associazioni: meno tasse, più certezze per chi affitta
Di fronte alla stretta fiscale, le principali associazioni del settore — da Confedilizia a Property Managers Italia, passando per Aigab e Aigo Confesercenti — non si sono limitate a criticare, ma hanno messo sul tavolo alcune proposte concrete. L’idea centrale è che, se l’obiettivo del governo è spingere i proprietari verso gli affitti lunghi, bisogna renderli più convenienti e sicuri.
Tra le proposte figurano: una riduzione del 50% dell’IMU per chi affitta a lungo termine, l’estensione della cedolare secca al 10%, già prevista per i contratti a canone concordato, e maggiori garanzie legali contro la morosità. Misure che, secondo le associazioni, sarebbero capaci di riequilibrare il mercato senza colpire chi ha investito legittimamente nel turismo residenziale.
Il timore diffuso, infatti, è che l’inasprimento fiscale possa spingere molti proprietari verso l’irregolarità o l’abbandono degli immobili, con effetti controproducenti per tutti.
Una riforma che divide: tra esigenze pubbliche e diritti dei privati
Il nuovo intervento fiscale del governo si muove su un terreno delicato, dove interessi pubblici e diritti privati si intrecciano in modo complesso. Da un lato, esiste l’esigenza di regolamentare un fenomeno — quello degli affitti brevi — che ha trasformato interi quartieri, svuotandoli di residenti e rendendo difficile trovare case a prezzi accessibili.
Dall’altro lato, la tassazione al 26% rischia di colpire indiscriminatamente anche chi affitta per necessità, riducendo le entrate familiari e incentivando l’abbandono del mercato regolare. In assenza di politiche abitative più ampie, che affrontino in modo strutturale il problema dell’offerta e della qualità degli alloggi, l’aumento della pressione fiscale potrebbe rivelarsi un rimedio peggiore del male.
Il nodo da sciogliere resta sempre lo stesso: come garantire il diritto alla casa senza compromettere il legittimo utilizzo dei beni privati?
Richiedi informazioni per Casa, Notizie, Tasse e Imposte
Articoli Correlati


Bonus edilizi: come cambia la tassazione dei crediti acquistati dal 2024
19/01/2026 09:49 - Dal 2024 il differenziale sui crediti edilizi acquistati da studi associati è imponibile ai fini IRPEF e IRAP. Nessuna tassazione per crediti comprati prima del 2024.

Cedolare secca e affitti brevi nel 2026: regole e controlli
15/01/2026 10:08 - Locazioni brevi più controllate nel 2026: nessuna nuova soglia fissa, ma criteri [..]

Proroga del contratto senza comunicazione: si perde la cedolare secca?
14/01/2026 12:55 - La cedolare secca va [..]

Locazioni brevi: quando il reddito diventa attività d’impresa
13/01/2026 17:04 - Dal 2026 le locazioni brevi sono ammesse solo fino a due immobili. Dal terzo, il [..]





















