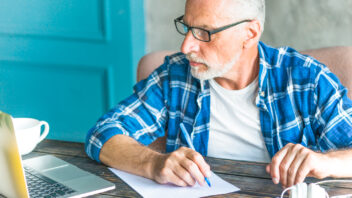Pensione INPS per casalinghi: come funziona il fondo dedicato
Il lavoro domestico non retribuito sostiene la società ma resta privo di un vero riconoscimento normativo. Esistono forme frammentate di tutela previdenziale, assistenziale e formativa per casalinghe e caregiver.


Cucinare, pulire, fare la spesa, accompagnare i figli a scuola, assistere i genitori anziani o un familiare non autosufficiente: sono attività quotidiane spesso invisibili, ma fondamentali per il benessere della società. Un lavoro di cura non retribuito che pesa quasi sempre sulle spalle di una sola persona, in gran parte donne, e che raramente trova un riconoscimento economico o previdenziale adeguato.
Nonostante l’importanza sociale di queste attività, il nostro ordinamento non ha mai introdotto un sostegno unitario, strutturato e riconosciuto per chi dedica la propria vita alla gestione della casa e della famiglia. Quando si parla di “bonus casalinghe”, infatti, si fa spesso confusione: non esiste un bonus unico o automatico, ma piuttosto una serie di strumenti sparsi, che richiedono requisiti specifici e una buona dose di informazione per essere utilizzati.
Ma quali sono concretamente le tutele oggi esistenti per chi svolge lavoro domestico non retribuito? Quali strumenti offre lo Stato per garantire un minimo di sicurezza a chi ha scelto — o si è trovato — a ricoprire questo ruolo?
Sommario
Il fondo di previdenza INPS per chi si dedica alla cura familiare
Per chi si occupa in modo continuativo della casa e della famiglia senza svolgere un lavoro retribuito, esiste una forma di tutela previdenziale poco conosciuta ma potenzialmente utile: il Fondo di previdenza per casalinghe e casalinghi, istituito nel 1996 e gestito dall’INPS. Si tratta di una forma di assicurazione volontaria, pensata per garantire un futuro pensionistico anche a chi, per anni, ha svolto attività di cura senza percepire uno stipendio.
Possono iscriversi al Fondo le persone tra i 16 e i 65 anni che non abbiano coperture previdenziali obbligatorie (come un contratto di lavoro attivo) e che si dedicano alla gestione del proprio nucleo familiare. I contributi sono liberamente versabili: non c’è un importo fisso mensile, ma per ottenere almeno un anno di contribuzione è necessario versare 309,84 euro all’anno (importo aggiornato periodicamente dall’INPS). Versamenti superiori, ovviamente, permettono di costruire una pensione più consistente.
Dopo almeno 5 anni di contributi, si può maturare il diritto a una pensione di vecchiaia, richiedibile a partire dai 57 anni se l’importo raggiunto supera una soglia minima, oppure automaticamente dai 65 anni. Il Fondo prevede anche una pensione di inabilità, nel caso in cui l’iscritto si trovi impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa e abbia almeno 5 anni di contribuzione.
Tuttavia, questo strumento ha dei limiti evidenti: non prevede un importo minimo garantito, e ciò significa che, in assenza di versamenti regolari e consistenti, la pensione finale rischia di essere molto bassa. Nonostante ciò, rappresenta l’unico strumento ufficiale oggi esistente per costruirsi una tutela previdenziale senza essere formalmente occupati.
Assegno sociale: un sostegno per chi non ha mai versato contributi
Per chi ha dedicato la vita alla cura della casa e dei familiari senza mai svolgere un lavoro retribuito — e quindi senza aver versato contributi previdenziali — l’unico strumento disponibile, una volta raggiunta la vecchiaia, è l’assegno sociale. Si tratta di una misura assistenziale erogata dall’INPS, destinata a chi ha più di 67 anni e si trova in una condizione economica svantaggiata.
Non è una pensione vera e propria, né è collegata all’attività domestica svolta: si basa esclusivamente sul reddito personale e familiare. Per il 2025, l’assegno pieno spetta a chi non ha alcun reddito e vive da solo, oppure a chi, in coppia, ha un reddito complessivo inferiore a circa 7.000 euro l’anno. Superata questa soglia, l’importo si riduce in modo proporzionale, fino ad azzerarsi.
È importante sottolineare che l’assegno sociale non è automatico: va richiesto all’INPS e può essere soggetto a verifiche periodiche sulla situazione reddituale e anagrafica del beneficiario, compreso l’eventuale trasferimento di residenza all’estero, che potrebbe farlo decadere.
Pur con i suoi limiti, rappresenta una rete di sicurezza minima per chi, dopo una vita spesa per la famiglia, si trova senza risorse economiche e senza una pensione. Non compensa certo il lavoro svolto, ma può garantire un minimo di autonomia nella terza età.
Assegno di inclusione: una nuova forma di sostegno per le famiglie fragili
Dal 2024 l’Italia ha introdotto l’Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico destinata alle famiglie in difficoltà che rispondono a precisi requisiti di reddito e composizione del nucleo. Pur non essendo pensato esclusivamente per chi si occupa della casa, l’ADI rappresenta una opportunità concreta per molte persone impegnate nel lavoro di cura.
L’assegno è rivolto in particolare ai nuclei familiari con minori, disabili, persone anziane sopra i 60 anni o membri presi in carico dai servizi sociali. In questi casi, l’attività di cura viene riconosciuta come impegno a pieno titolo, tanto che il caregiver familiare può essere esentato dagli obblighi di attivazione lavorativa o formativa normalmente previsti per i beneficiari della misura.
Per ottenere l’ADI, è necessario avere un ISEE inferiore a 9.360 euro, non possedere beni patrimoniali o immobiliari superiori a soglie prestabilite, ed essere residenti in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. L’importo dell’assegno varia in base al numero dei componenti e al reddito del nucleo, e può essere integrato con contributi per l’affitto.
Questa misura, sebbene non esclusivamente dedicata a casalinghe e caregiver, rappresenta un segnale di attenzione verso le situazioni di fragilità familiare, e offre un minimo di riconoscimento economico per chi svolge quotidianamente compiti di assistenza e cura.
Formazione e reinserimento: le opportunità offerte da comuni e regioni
Accanto alle misure nazionali, esistono anche numerose iniziative locali, promosse da Comuni e Regioni, pensate per supportare chi ha svolto per anni attività di cura familiare e desidera oggi aggiornarsi o rientrare nel mondo del lavoro. Si tratta di programmi spesso poco pubblicizzati ma preziosi, che variano a seconda del territorio e dei fondi disponibili.
Tra le opportunità più diffuse ci sono i corsi di formazione e riqualificazione professionale, spesso finanziati con fondi europei o regionali. Questi corsi possono riguardare competenze digitali, amministrative, artigianali o legate al settore socio-assistenziale, e sono generalmente gratuiti o fortemente agevolati. In alcuni casi, è previsto anche un rimborso spese per chi partecipa o un piccolo incentivo economico.
Alcune amministrazioni locali prevedono anche contributi per avviare un’attività autonoma, come il microcredito o i bandi per l’imprenditoria femminile, pensati proprio per chi ha bisogno di un nuovo inizio dopo anni lontano dal mercato del lavoro.
Queste iniziative hanno un duplice obiettivo: da un lato valorizzare le competenze maturate nel contesto familiare, dall’altro fornire strumenti concreti per recuperare l’indipendenza economica. Ma per poterne usufruire è fondamentale informarsi presso il proprio Comune di residenza o i centri per l’impiego, perché spesso si tratta di bandi a scadenza o su disponibilità limitata.
Un lavoro invisibile che vale più di 700 miliardi
C’è un dato che dovrebbe far riflettere: secondo l’Istat, oltre il 90% degli italiani tra i 20 e i 74 anni svolge ogni giorno attività domestiche o di cura non retribuite, per una media di oltre tre ore al giorno. Se si somma questo impegno all’intera popolazione, si ottengono centinaia di milioni di ore di lavoro quotidiano, il cui valore economico stimato supera i 700 miliardi di euro l’anno — circa il 40% del PIL nazionale.
Numeri impressionanti, che raccontano quanto il lavoro di cura — pur non retribuito — sia un pilastro dell’economia e del benessere sociale. Eppure, a fronte di questa enorme mole di lavoro, non esiste ancora una legge quadro o un bonus universale che riconosca il ruolo di chi si prende cura della casa e della famiglia in modo continuativo.
La Costituzione italiana, all’articolo 35, tutela il lavoro in tutte le sue forme, e già nel 1995 la Corte Costituzionale ha affermato che anche il lavoro domestico merita protezione giuridica e sociale. Tuttavia, tra il principio e la realtà c’è ancora un vuoto normativo: chi svolge questo ruolo oggi si muove in un sistema frammentato, fatto di previdenza volontaria, misure assistenziali e bonus locali, senza una tutela unitaria e strutturata.
Richiedi informazioni per Economia e Finanza, Notizie, Pensioni
Articoli Correlati


Pensioni 2026: cosa prevede la Legge di Bilancio e cosa cambia rispetto al 2025
02/01/2026 12:41 - La Manovra 2026 conferma i requisiti base, elimina Opzione Donna, limita il cumulo della previdenza complementare, riduce le risorse per i precoci e aumenta di 20 euro le pensioni minime.

INPS: arriva il bonus pensioni di Natale di 154,94 euro per i redditi più bassi
18/11/2025 10:25 - Nel dicembre 2025 i [..]

Pensioni 2026: cosa cambia davvero con la rivalutazione del 4,04%
05/11/2025 11:54 - Nel 2026 le pensioni [..]

Pensioni 2025: i nuovi coefficienti di trasformazione, guida al calcolo pensionistico
10/12/2024 09:00 - La revisione biennale [..]